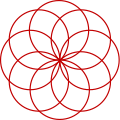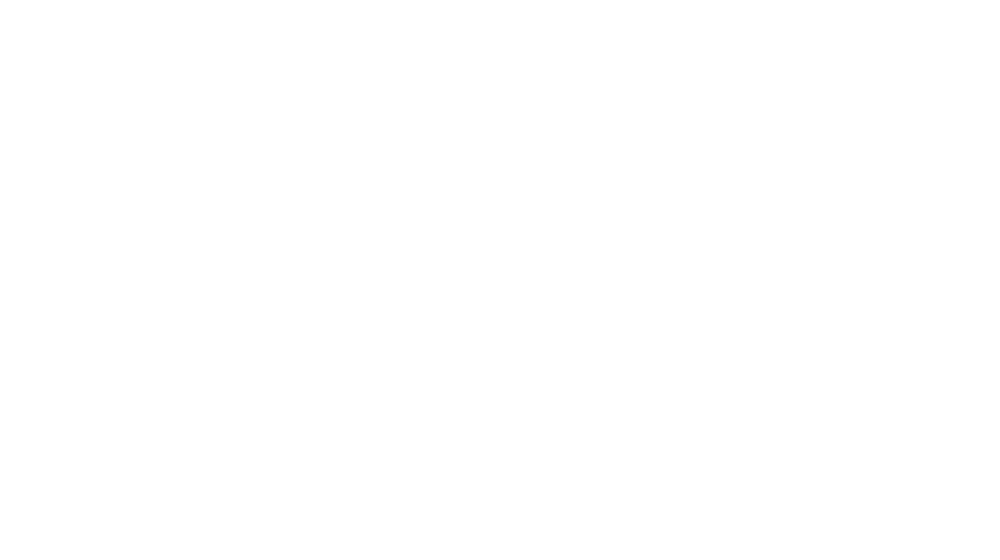con una nota critica di Maurizio Casagrande
Gò da confesave na roba, on małe
Ca gò in tel cuore e pàłe man.
Veło scrivo só ’n tòco de carta
Sto sghiribìsso sensa arte né parte,
Ma xe tuto vèro. Gò na varrgògna
Grànda senpre. Me sento in colpa
Ànca se nó gò fato gnénte.
De nó fare gnénte. Cuà xe tùto gnénte.
E cuéo cà digo e fasso sparisse co fà ła nève
De Marxo. Co fà eła ‘uce in ombrìa.
Devo confessarvi una cosa, un peccato / che ho nel cuore e nelle mani. // Ve lo scrivo su un foglio / Questo scarabocchio senza arte né parte, / Ma è tutto vero. Ho una vergogna // immensa. Mi sento in colpa / anche se non ho fatto niente. // Di non fare niente. / Qui ogni cosa è senza valore. / E quel che dico e faccio sparisce come neve // di marzo. / Come luce nell’ombra.

*
Penso ca i morti i ne scólta.
I ne sente a mexo bòto criàre in łeto.
I ne vàrda magnàre el dì de Nadàe
Sói e spòji. Nudi e nàdi, pà queło kea xe.
No i vòe sentarse in tóła bévare n’ombra.
Tałora i ne pòxa na màn ssó ła testa,
E i càva fóra i pensièri dałe récce.
O dàłe narixe. Xe istesso.
E me vién da rìdare, ca xe tùta na buxìa.
Penso che i morti ci ascoltino. / Ci sentono all’una di notte piangere nel letto. // Ci guardano mangiare a Natale, / Soli e spogli. Per ciò che siamo. // Non vogliono sedersi a tavola a bere un bicchiere di vino. // Talora ci appoggiano una mano / Sulla testa, e ne tirino fuori i pensieri dalle orecchie. / O dalle narici. Fa lo stesso. // Rido, perché è una bugia.
*
Àła fine fasso ànca pecà.
Cuà có łe me carte e i me łibri, ónto cofà na ssépa.
Sò squàxio on cagnéto ca’l scaìna a róta de cóło,
‘Pena ca’l ‘ede dù putèi xugàre fora deła só corte.
On bixàto in tel banco del pesse (de quei da Cioxa,
Al marcà Agna), limegóxo in teła só llèa.
Na ssàta róta. On dente ca’l dòe.
Ja ssìngana méxa indormessà
Sóto i pórteghi, in parte ła banca:
No sénte e no parla – ma tuti vàrda.
Alla fine faccio anche pietà // Qua con le mie carte e i miei libri, sporco come una seppia. // Sono come un cagnolino che guaisce, / Appena vede dei bambini giocare fuori dal cortile. // Un’anguilla nel banco del pesce (di quelli da Chioggia, / Al mercato di Agna), unta della sua bava. // Una zampa rotta. Un dente che duole. // La zingara mezza addormentata / Sotto il portico, al lato della banca: // Non sente e non parla – ma guarda tutti.
*
Go pensà tante ‘olte de coparme.
Nàr sù in téxa, łigàrme al coeo
Na corda, e picàrme co fà na bóndoła.
Ma no ve meritè gnà ła fadiga morire,
E de vegnèrme rómpare l’anima
F’ìn ssimitèro a criotàre, o n’dar torno:
“Al jèra proprio on brào toxo, mai on torto
Mai on dispèto… che pecà k’al xe morto.”
Se me cópo xe sóło ca colpa vostra.
Ho pensato tante volte di uccidermi. // Di andare in solaio, legarmi una corda / Al collo, ed impiccarmi. // Ma non meritate la fatica di morire, / E di venir a disturbare / Il mio riposo, o dire: // “Era proprio un bravo ragazzo, / A modo… peccato sia morto.” // Se mi uccidessi, sarebbe solo colpa vostra.
*
Có sirò morto, spero ca nà panegàssa mòra
Me portarà na frégoła de pan, on jósso de vìn,
Na ciacołéta de piassa. El recìn de kea tóxa sorda
Ca me piaxéva có ‘ndava dałe mùneghe.
Na monàda pà farme vegner inaménte
Ca anca mi so stà có viàltri on dì.
Ah, cari mìhi; ndaremo insieme uncóra e senpre.
Quando sarò morto, spero che un passero / Mi porti una briciola di pane, un goccio di vino, // Una chiacchiera dalla piazza, l’orecchino di quella ragazzina sorda / Che mi innamorava quand’ero bambino. // Un’inezia per ricordarmi / Che anch’io son stato con voi. // Ma, cari miei, un giorno andremo ancora e sempre assieme.

*
Cuesta xe ła tèra dei me morti.
De me nòna, e de mé nòno.
Del tribołare de mé opà,
Dei sïori ca no semo mai stà.
Del la’oro ke’l mai basta.
Cuesta xé ła tèra dei suori e dełe biastéme.
Dei cavéji bixi. Dełe ónge ónte.
Dełe bràghe de fustagno.
Dełe camìxe fate sù fìi gumbi.
Cuesta xe ła łengua che cavo de bóca ai mé morti.
Parché mi no gò pì fià. E nó so bón sdebitarme.
Questa è la terra dei miei morti. / Di mia nonna, e di mio nonno. / Della fatica di mio padre, / Dei signori che non siamo mai stati, / E del lavoro che non basta mai. // Questa è la terra della fatica e delle bestemmie. / Dei capelli bianchi. Delle unghie sporche. // Dei pantaloni di fustagno. Delle camicie / con le maniche arrotolate. // Questa è la lingua di cui privo i miei morti. // Perché non ho più respiro. E non so sdebitarmi.

Carlo Ragliani (Monselice, 1992) vive a Candiana (PD), studia giurisprudenza. È redattore di “Atelier Online” e “Laboratori Poesia”. Suoi testi sono apparsi su antologie e riviste letterarie, tra cui “Il Segnale”, “Poetarum Silva”, “La Balena Bianca”, “Inverso”, “Carteggi letterari”, “Niedergasse”, “Atelier”. Ha pubblicato Lo stigma (ItalicpeQuod, 2019).
***
Nota a cura di Maurizio Casagrande
Una voce dai campi: Tèra, di Carlo Ragliani.
Il titolo stesso della silloge con cui Ragliani si propone al lettore con queste sue primizie nel dialetto di Candiana delimita il raggio del compasso entro il quale si muove con naturalezza il poeta, radicando allo stesso tempo l’opera nei recessi meno nobilitati delle campagne padane, che non costituiscono puramente e semplicemente uno sfondo o la quarta teatrale di una scena, bensì incarnano l’anima dei luoghi, come quella dei tempi. Allo stesso tempo il titolo allude ad un forte radicamento al primo dei quattro elementi, lasciando intravedere in prospettiva un ulteriore sviluppo di tale poetica nella direzione dei tre restanti (aria, acqua e fuoco).
Non meno plastico e terrigno risulta il codice espressivo, che nasce quale filiazione indubbia di una variante locale e tuttavia manifesta caratteri tali da consentirci di parlarne piuttosto in termini di “neopavano”, in un’ampia oscillazione di registri che attingono al patrimonio linguistico di un vasto areale regionale, mentre – sul dominio ancora più esteso della cronologia – ci si muove dalle maschere caricaturali di Plauto, accreditate della patina rusticana del Ruzante, con significative tangenze al “pernumian boaro” di Emanuele Munari meglio noto come Anonimo da Piove, fino alla variante “meschissa” e quasi liquida di Sandro Zanotto, non senza attinenze col polesano nella declinazione che ne davano, fra gli altri, Gino Piva o Eugenio Ferdinando Palmieri.
Questa lingua atavica per non dire archetipica, dal colore e dalle tonalità perfino ctonie, sembra quasi la materializzazione delle zolle rivoltate dal vomere: lingua terrigna per antonomasia, sapida e pastosa che costituisce di per sè un sicuro guadagno, sufficiente, da sola, ad imporre l’autore all’attenzione del pubblico, se non della critica.
Ma l’arcaicità della lingua nasconde pure un altro risvolto, cioé a dire quell’afflato religioso che, non essendo sostenuto da una manifesta professione di fede nelle confessioni storiche, finisce per tradursi e sconfinare sovente in forme di neopaganesimo di ritorno, le medesime, a ben vedere, che la chiesa stessa non era riuscita ad estirpare del tutto neppure nella stagione della Controriforma, dopo che avevano attecchito nelle nostre campagne sin dal tardo impero, mentre nella produzione in lingua esso assume piuttosto le forme di un sincretismo panico sulla lontana suggestione di Ungaretti e D’Annunzio.
Per inciso, peraltro, la lezione del primo Ungaretti è ravvisabile anche in Tera, e in maniera più scoperta proprio nella lirica d’apertura Cuesta xe ea tèra dei me morti che vale a stabilire un dialogo a distanza rispetto alla celeberrima I fiumi, ma con uno scarto significativo nella focalizzazione passando dall’ambiente naturale agli umili e alla loro storia attraverso le metafore del sudore, delle unghie sporche o delle bestemmie, come pure, e soprattutto, dai vivi ai morti con punte di espressionismo che rimandano a Delio Tessa.
A questo modo inoltre si viene profilando sin dalle prime battute quell’intreccio indissolubile fra la vita e la morte, la terra e l’oltre, che attraversa e sostanzia l’intero libro, davvero potente come esordio in dialetto, col risultato di attingere la dimensione del sacro e dell’universale battendo la via del negativo e dell’antifrasi,
Viene da qui, plausibilmente, ovvero dal retaggio delle superstizioni popolari e del vissuto contadino, insieme a un possibile influsso esercitato dai modelli di Piva e Palmieri, la frequenza con cui ricorre la presenza dei defunti e la familiarità nella relazione che il poeta viene a stabilire con loro. Su tale terreno una prossimità altrettanto forte si avverte, a pelle, rispetto al veneziano Della Corte: più che nella lingua, nell’approccio duro e disincantato alla realtà, soprattutto per quel che attiene alla tematica erotico-amorosa di cui Ragliani opera un sistematico capovolgimento parodico, quasi a voler prendere le distanze dal modello illustre della lirica d’amore; una durezza, si vorrebbe quasi dire una ferocia, che il poeta rivolge persino contro se stesso con particolare evidenza nei versi che seguono, con una lontana eco dantesca nel congedo dal pellegrino infernale da parte di Lapo da Siena nel canto dei suicidi: “Go pensà tante ‘olte de coparme. // Nàr sù in téxa, łigàrme al coeo / Na corda, e picàrme cofà na bóndoła.” (“Ho pensato tante volte di uccidermi. // Di andare in solaio, legarmi una corda / Al collo, ed impiccarmi.”, Go pensà tante ‘olte de coparme, p. 31).
E arriviamo così all’istanza crucis del libro, vale a dire la sua manifesta crudezza tematica, che è poi la modalità di approccio al mondo da parte dell’autore, emblematica, appunto, di una condizione di disagio rispetto all’esistente e al presente, di un profondo turbamento e, a tratti, quasi di una scoperta disperazione, quella “disperata vitalità” che era già di Pasolini, Beppe Salvia, Simone Cattaneo o di altri grandi, formulata però in dialetto e in un’oscura variante della bassa padovana!
È riconoscibile inoltre, nella sapiente tessitura delle battute di dialogo, come nella centralità dell’io lirico nelle multiformi maschere che questi viene calzando di volta in volta, una chiara vocazione alla drammatizzazione teatrale che avvicina Ragliani da un lato agli esiti del già citato Palmieri, dall’altro a quelli del veronese (ma originario di Cavarzere) Renzo Favaron, oltre ovviamente ai parlamenti di Angelo Beolco.
Né andranno taciute la distanza che si viene a produrre fra testo di partenza e versione in italiano, talvolta persino macroscopica, particolare tanto più significativo trattandosi di un poeta attivo anche in lingua, come pure le singolarità grafiche, alquanto estranee ai dialetti veneti della bassa padana, nelle opzioni per la dieresi vocalica, per la velare kappa in luogo della “c”, per la muta intervocalica, o per la barretta sulla “l” (vezzo quest’ultimo su cui già Lele Munari formulava fondate perplessità nella sua introduzione al Purgatorio de Dante libaramente voltà in dialeto padoan bifolco, Rebellato 1982).
Al di là di tutto, comunque, valga quale garanzia di autenticità e professione di intenti, non meno che di poetica, questa confessione affidata ad alcune strofette lapidarie che non lasciano adito a dubbi:
“Gò da confesave na roba, on małe / Ca gò in tel cuore e pàłe man. // Veło scrivo so on tòco de carta, / Sto sghiribìsso sensa arte né parte. / Ma xe tuto vèro. Gò na varrgogna // Grànda senpre. Me sento in colpa / Ànca se no go fato gnente. // De nó fare gnente. Qua xe tuto gnénte.”
(“Devo confessarvi una cosa, un peccato / che ho nel cuore e nelle mani. // Ve lo scrivo su un foglio, / Questo scarabocchio senza arte né parte, / Ma è tutto vero. Ho una vergogna // immensa. Mi sento in colpa / anche se non ho fatto niente. // Di non fare niente. Qui ogni cosa è senza valore”, pp. 14-15).
Maurizio Casagrande è nato a Padova nel 1961. Per le edizioni Il Ponte del Sale di Rovigo ha pubblicato In un gorgo di fedeltà (2006), volume di interviste a venti poeti italiani, la raccolta d’esordio Sofegón carogna (2011) e un commento al Canto XXIII del Purgatorio dantesco incluso nell’opera collettanea Ombre come cosa salda (2011). Ha curato le antologie In classe, con i poeti (puntoacapo 2014) e, con Matteo Vercesi, Un altro Veneto. Poeti in dialetto fra Novecento e Duemila (Cofine 2014); del 2015 sono le sillogi Pa’ vèrghine ave, la plaquette Soto ‘a nogara; del 2018 In sènare; nel marzo del 2019, per Il Ponte del Sale, ha pubblicato la silloge Dàssea ‘nare; nel 2020, per Medusa, Co ‘a scùria.