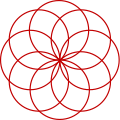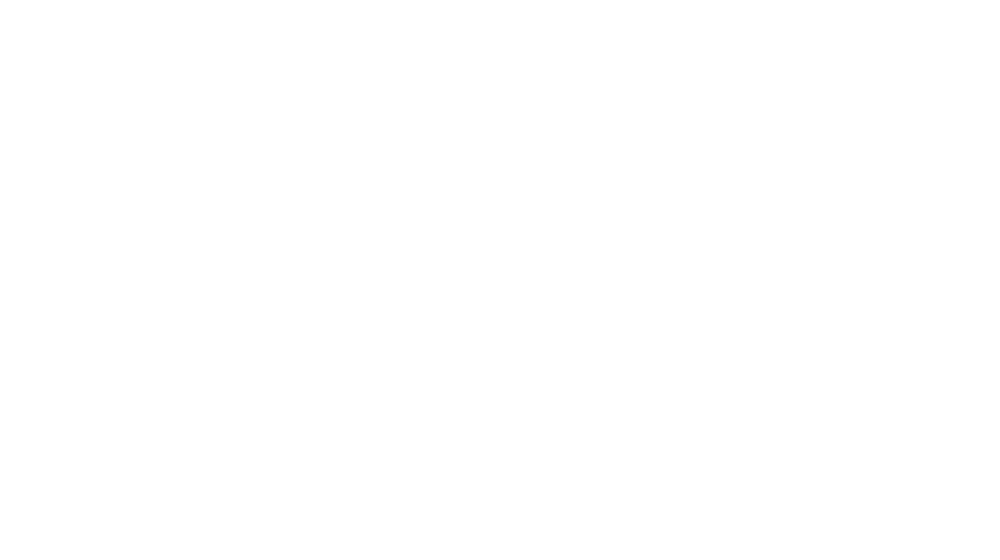«Avvertirai la gravità pungerti / come una spina nel calcagno / e per l’imperativo delle ali avrai male alle scapole. / Ti prometto di renderti talmente vivo che / la polvere ti assorderà cadendo sopra i mobili, / che le sopracciglia diventeranno due ferite fresche / e ti parrà che i tuoi ricordi inizino / con la creazione del mondo»: così Nina Cassian prometteva all’amato una filigrana del sentire, che dilatasse la percezione della realtà fino a renderla avvolgente e assoluta come l’involucro del giorno: dono d’amore e sortilegio, che sapesse dare a un’inezia l’immensità del tutto, e la durata del sempre, per un istante (Nina Cassian, C’è modo e modo di sparire, trad. Anita Natascia Bernacchia, Ottavio Fatica, Adelphi, 2013).
Questa capacità di fermare il tempo e divaricare lo spazio, rendendo radianti e grandiose ai sensi le cose minute, è una caratteristica fondante della poesia di Francesca Serragnoli, ribadita nell’ultima sua silloge La quasi notte, recentemente data alle stampe da MC edizioni, per la cura di Pasquale Di Palmo (Gli insetti, 2020).
Ma, a proposito di questa raccolta, è pure necessario convocare l’universo di Cristina Campo, presenza numinosa tra le pagine di Serragnoli, che scriveva, sulla poesia: «Il massimo del sapore non lo gustiamo mai nelle parole rare o in quelle del costume […] ma nelle pure e originarie – nel reale – quando siano sospinte dalla forza vitale come da una matrice e sboccino nella chiarezza dello spirito come fiori». (CC, Gli Imperdonabili, Adelphi, 1987).
Perché davvero questi due prodigi accadono, esili e tesi di luce, nei versi di Francesca, che pare sodale a Cristina anche in una non comune spiritualità, fulgida in trasparenza, declinata in levare: una poesia, la sua, che rifugge dall’aulico, dall’ostentata complessità del fraseggio, e in cui non si sente occhieggiare alcuna posa; piuttosto, sul palmo della poetessa, paesaggi di oggetti esigui si animano di significati sussurrati, colti con l’attenzione che Simone Weil diceva farsi preghiera. Alcune austerità prendono il volo in liriche levitazioni, ma in parola misurata, nel gesto accennato; è allora che certe immagini particolarissime rimangono come ologrammi nell’aria, in sospensione; e sono epifanie impalpabili, lambite dal sacro, se pur nate dall’umile e dal quotidiano: «Il vetro dell’Eurostar trattiene un’ombra / ferita da un riflesso / una divinità passeggera / che ha nei miei occhi / le sue candele».

Accanto a questo, la capacità peculiare di Serragnoli di rallentare l’evocato poetico, fino a espandere pulsati puntiformi, creando il fermo immagine perfetto: «dicono che la quasi notte / abbia tempo di fissarti / prima che gli storni avvolgano l’aria». Quest’attitudine, evidente fin dal titolo, pervade tutta l’opera, ed è il supporto alato che ci reca l’emozione, e che, in aerea leggerezza incide e, nel soffio trattenuto, deflagra: «L’alba è matura / e recisa / nel tuo volto bivacca il mio cuore / si alza in piedi solo per tremare / una candela lo tiene fra le mani / come un labbro in agonia».
La parola ha qui una potenza posata, riavvolta in sé, che si monda degli eccessi prima di esporsi, e distilla in mite contemplazione sovrane altezze; questo richiama ciò che Campo diceva di Chopin, compositore dal «metronomo sempre terzo e sempre in moto» sul quale misurava e frenava «i rubati i turbati, l’estasi stessa», a far sì che «la mano sinistra» fosse incessante «maestro di cappella» a serbare norma e discrezione dell’esprimere.
Eccola, la sprezzatura del Castiglione, divenuta pietra miliare campiana: la trascurata maestria che convoca le desolazioni dell’umano con pacatezza, con sguardo mansueto, che tutto solleva dal basso, e racchiude tra le ciglia, in accoglienza aperta, facendo eco a immensi spazi interiori; ciò che, nella sua forma più alta e mistica, è il saper vivere lasciando, il saper evocare la bellezza e l’assoluto dell’attimo senza ancorarvisi, ma «saltando sui sassi», come dice Serragnoli in alcune sue note a margine: «di luce in luce», essendo ogni volta chiamati, nell’arte, ad «andare oltre».
Questo saper sentire forte riportando piano, ma con docile intensità, trema di nitore nelle parole che la poetessa cita in epigrafe all’ultima sezione, e «la cui lettura è estenuante e sfuggente, come qualsiasi rito»; quell’indimenticabile verseggiare di Hugo von Hofmannsthal riportato da Campo negli Imperdonabili, che sigilla il mistero dell’esistenza in pochi cenni: «Con lieve cuore, con lievi mani, la vita prendere, la vita lasciare». Ed è così, con la stessa grazia affilatissima, dal portato assoluto, che la poetessa corica nel verso, in tenue ferocia, le sue meditazioni, intrise di terrena verità, di sofferenza introflessa, spalancata in silenzio: «Dal mio cuore evapora / l’alzarsi e l’abbassarsi del vivere // questo è il luogo dove il tempo / ha la testa schiacciata da un raggio di sole // l’eternità, madre di ogni lacerato addio / ci tiene per mano».

Un dire nonostante, senza gridare, immergendosi in certe consapevolezze quiete, con irrevocabile, efferata dolcezza: «un giorno da questa finestra / cadrà la mia vita / un tonfo lieve di palpebre / la bocca aperta / come alla prima comunione»; riportando nel vigore del percepire, a sismografo di realtà, sensazioni come «il cigolio della carne», il «rintocco che lacera la piazza», «L’odore di scoglio / rappreso in un sasso di sangue», «l’acqua ricamata di brividi»; rimanendo in questo fragile nostro corpo, che rotola attraverso rivoluzioni silenziose: «È l’ora della pietra/ l’ora che rotola via la vecchia testa // nell’umido marmo museo di questo ventre / dorato come un tempio / sporcato di pietà / di piccioni dal pianto nero».
Una postura poetica che raggiunge la sua massima potenza in un musicale pianissimo, nel sinestesico, nel punto di osservazione celato, laddove il poeta, facendosi cosa piccola, percorre il reale in punta di sguardo, senza sfinire o deformare, eppure dicendo; e, con tocco garbato, divarica baratri in petto: «Vivrò ai margini di quel sorriso di neonato / come i signori che dormono in terra / con la vita tutta lì / poco più alta di un fiore // quel sorriso alato / poserà e alzerà la sua farfalla / come sotto al pesco / un’ombra matura / allungandosi / stacca la sua morte», e ancora: «Tutto nel mondo è piccolissimo / cade in terra come i bambini / ti guarda con occhi impietriti / un secondo prima di piangere».
Fin dalle raccolte precedenti, colpisce questa profondità semplice, che lascia immobili, nel dire il dramma collettivo dell’essere umano, la sua sofferenza a flettere al corso delle cose, in eterna dialettica tra spirito e materia: «c’è un male che mangia la luce / la notte è un pane secco / io sono quel nulla che dice no / premo per nascere» e il dramma personale dell’individuo, nelle affettività inesaudite, nelle desolazioni che chiudono all’angolo: «i tuoi occhi/ sono sbarre di ferro/ dove poso braccia impolverate. // Avrà colore / questo buio salato / questo mare che farfuglia in bocca?» (Francesca Serragnoli, Il fianco dove appoggiare un figlio, Raffaelli, 2011).
Serragnoli appare, nell’intera sua opera, un ossimoro di spoliazione e magistero insieme, perché, semplicemente, incanta col suo modo di accostare le parole: pietre di arenile, stondate in sobrietà, ma colme della perizia e della memoria dell’acqua, imbevute di testimonianza silenziosa; una poetessa che sa atterrare cauta nel pianeta dei fiori, dei bambini, e con lo stesso candore visitare i territori adulti del rimpianto, del mancato, avvicinandosi a ogni creatura con la grazia della compassione: «C’è una chioma grigia, un merletto / di capelli che spunta dal lettino / una ambulanza calma, un vecchietto / legato con le cinghie / di fianco una giovane donna dell’est / prende accordi con gli autisti […] // L’altopiano più alto del canto è l’uomo / che non sa esistere, non aiutato» (Francesca Serragnoli, Il rubino del martedì, Raffaelli, 2009).

Sempre accanto, la consapevolezza di un tempo che non ci appartiene, scandito da autorità intrinseche al creato, delimitante stagioni che nulla rendono conto al cuore: «Dio e la vita / a tirare corde di campane / come se il tempo impiccato / morisse in una musica».
Lo splendore in poesia, diceva Campo, è soprammercato di giustizia; come nella natura, «che è bella solo per necessità reale, così anche nell’arte la bellezza […] è il frutto inevitabile della necessità ideale»; e von Hofmannsthal, in antifona: «L’intero universo è colmo di significato, è senso divenuto forma […] i poeti fanno in tutto e per tutto come i compositori, esprimono cioè la loro anima per mezzo di qualcosa che si trova sparso per l’intera esistenza – poiché l’esistenza ha in sé la totalità di tutti i suoni possibili – ma tutto dipende da come li si combina» (Hugo von Hofmannsthal, Le parole non sono di questo mondo, Quodlibet, 2008).
Giovanna Sicari, sorella celeste di Francesca in amicizia e in poesia, scriveva: «Chi si prende cura di noi / in quel battito d’ali è il flusso divino ed il respiro. / In questo vuoto e compassione, in questa zona / fuori legge ci si può salvare»; questa zona fuori legge è quella del poeta, che, come l’eroe di fiaba, si ribella all’ineluttabile, abita il sopramondo, e vola alto sulle desolazioni della carne, pur non dimenticandole: «e di niente io voglio vivere / ma le mani / cosa sono diventate le mani / chiuse come case abbandonate»; e ancora, proprio accanto a Giovanna, nel senso più profondo del termine, Francesca scriveva: «Non mangi più / nei tuoi occhi il pane è il tempo / che avviene oltre il vetro […] come chi posa le ali pregando / che qualcuno ne chiami il volo / che il cielo lo liberi / nel viaggio che fa tremare gli alberi […] e ci sarà l’alluvione / quel tornare verso il mare, fuori Roma. // È lì che slegano le campane / come sbendassero le tue gambe / dalle sottane di questo letto / ora che la croce è vuota / ed è quasi domenica».

Qui l’essenza della poesia: sguardo limpido, svuotato di sé, che arde solo di amore, e diviene mistica intera.
Ed ecco che in lucentezza si disciolgono anche l’inquietudine e il trasporto dell’amore erotico, che precipita negli azzardi della sua intensità: «sentivo il ragno risalire / nella sua brezza di drago / legarmi in cerchi di seta // ero l’immobile creatura / con il mare alla bocca / che non muove nulla per vivere», ma anche vola nel suo puro incanto: «Quando due mani si sfiorano / sguscia via il tuorlo intatto dell’alba / le attraversa un addio di grazia, una gola, / ostile ai ganci, alle promesse / divaricata come nelle nascite».
Con La quasi notte – piccolo volume soffice e acuminato, intimissimo – la contemplazione del vedere e dell’udire, educata ad ascesi di weiliana attenzione, ha cura di ciò che, in aperto fluire, ci circonda e si eleva dalle radici dell’essere, restituendolo in materia riplasmata, in cui elementi trasfigurano in altri, e si presentano in nuova fisionomia e presenza: si ridisegnano senza sosta le relazioni tra le cose, in una poiesis che rende ragione al proprio etimo.
Accorto, Di Palmo in prefazione nomina una «parola sussurrata a fior di labbra, che ha la compostezza di una rosa coltivata interiormente». Ed è questa l’immagine regale, delicata, definitiva, che accompagna e fa rimanere assorti, con il libro appena terminato tra le mani.
Isabella Bignozzi
*
Un giglio d’acqua fra le ciglia
le radici spaccano il viso alla pioggia
chiamano il cielo
come un gatto struscia il blu al suo Dio
la zampa gioca agli occhi
o è una buffonata il pianto
e un catetere desolante lo raccoglie?
Gli occhi spaccati in due
e un funambolo tra le travi attraversa il grido
è la vita all’altezza della vita
nelle mani null’altro

*
Chi è solo porta a spasso
il cane del suo volto
s’incatena a sé
in un groviglio freddo
copre una panchina
somigliano a un uomo
a un portachiavi
e non apre niente
la loro sera
*
L’ultima parola detta
fa il suo giro nel sangue
il ghiaccio del viso
intorno alla bocca
crepa una gioia leggerissima
*
Anche i piccoli dolori scuciono lo sguardo
escono fili sottilissimi
la vergogna di essere tristi
si staccheranno da soli, mezzo seccati
vedrai gli occhi più piccoli, marroni
al centro una goccia
oscilla e non cade
rimane lì tutta la vita.

*
La profondità del lago mi fissa
la superficie vibra battuta da un ventaglio
come il salice vorrebbe sfiorare l’acqua
la mia ombra s’inclina
l’infinito è quel centimetro enorme
sgualcito dove la vita spinge
la testa per passare
nella stanza l’arazzo lava i miei colori
un panno che mani bianche
alzano e abbassano da un cesto
scendere ricorda i movimenti di una culla
risalire ha la bruciante paura dell’acqua
di evaporare, diventare niente
il sole scuce la rosa del volto
l’orlo increspato di un vestito
l’onda è vapore, salsedine
goccia che riconosce una spalla non sua
l’oro blu della quasi notte, nient’altro
dà al fiore l’ultimo tremito.