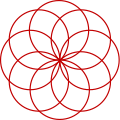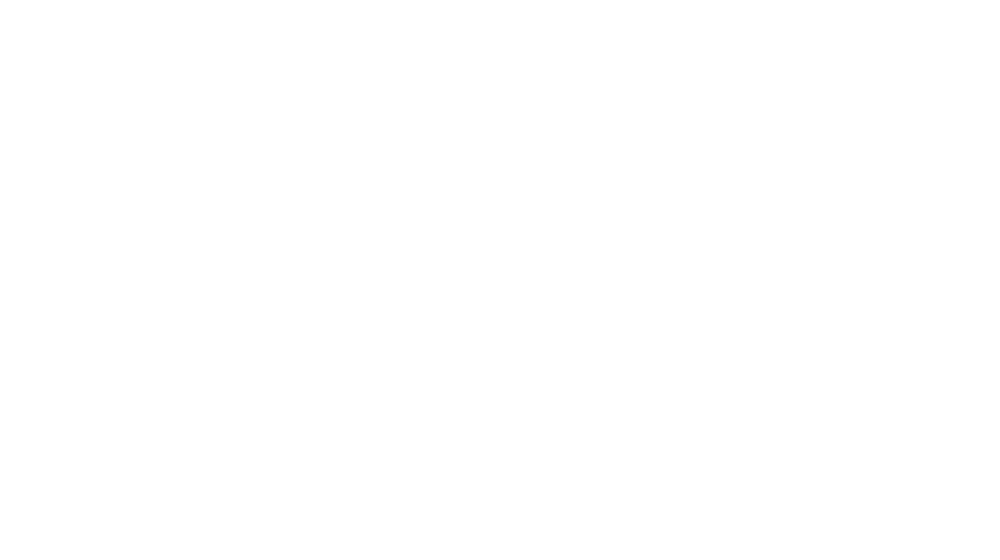Samuele Editore 2023
Pordenonelegge, collana Gialla Oro
Apparentemente contornata, la materia di continuo tradisce e si sfalda. Un universo di corpi instabili verte al disfacimento, ad ammassi primordiali di ritorno: benedetti di cruda nuova fertilità, in cui il grido silenzioso del singolo, dissolto, si spegne senza accento, senza ascolto.
Questa la smagliatura – fuori dal campo visivo del cieco positivismo – che rende vacuo il delirio dell’ottimizzazione, del mettere a profitto ogni risorsa ambientale e creaturale sia sotto il cielo.
Nello smarrimento del percorso interiore, nella perdita di ogni coordinata esistenziale, l’anima sensibile non sa tuttavia ignorare la propria matrice nucleare: parte di quell’origine che, come uno scandaglio, ne trova il punto ancora vivo, e lo riconduce a sé col dolore.
È di questo avvilimento, sebbene in termini neutri, scevri di qualunque tensione pedagogica, che scrive Mario De Santis nella sua più recente opera poetica Corpi solubili (Samuele 2023, Pordenonelegge, collana Gialla Oro): qui il poeta plasma, in forma di scrittura lirica, un accorato diario di vita, di portata trentennale; affidabile perché di ampio respiro, come le valutazioni climatiche: resoconto intimo che approda a sguardo vasto e condiviso su questo nostro radicale, tardo materialismo: una cronaca di sparizione e dissoluzione che, in dialettica con la morselliana Dissipatio, è tanto più spettrale, perché avviene in presenza.
De Santis registra in modo magistrale, desolato, il fallimento: di quella flessione antropocentrica del reale che l’uomo, avvinto al suo delirio primatista, ha tentato; ponendosi sulla via della programmazione funzionale di ogni risorsa ambientale, di ogni respiro; in un universo di cui conosciamo solo parte infinitesima, e che solo in minima parte possiamo disciplinare.
Siamo oltre il tramonto dell’illusione: in Corpi solubili siamo nel disagio che enumera, senza risposta; che descrive la china di un genere umano che, sedotto da confortevoli immanenze, istruito alla sistematica diffidenza verso l’invisibile, non trova più il senso profondo della vita.
Così, nel muto chiasso di un fluire divenuto inspiegabile e malevolo, che disgrega le installazioni, perde i legami, annebbia ogni identità, nella incessante sparizione e dilatazione entropica del tutto, la materia naturale col suo gelido, equanime splendore, disperde sé stessa verso immensità che del genere umano non si curano. Progresso e tecnologia viziano e illudono il singolo di compiutezze terrene, di perpetuità non date, ma poi lasciano in esistenza impari, perplessa; nell’inesaudito, che non ha saputo mettere nulla, dell’esperienza fisica, a dimora spirituale.
De Santis cerca perentorietà: persino fosse crollo, disfatta tagliente; che segni un margine, un nuovo asse, un riorientamento – da cháos a kósmos – pur a costo di spietata palingenesi. Ma non è dato che questo dissolversi lento, languido: un declivio soporoso, in cui non vi è più rito, né cosmogonia. Nella rapidità digitale, nella distopia del tutto che appare e svanisce, la vita vera non ha più propulsione; e ogni freschezza è già disincanto.
Innegabile solubilità: tutto ciò che è immanente, e narcisisticamente nominale, tradisce la propria stessa struttura, disgregandosi; nondimeno ogni senso precario e singolo riconfluisce nell’universale: imprendibile infinità, sempre incolume, che tutto discioglie e miscela, rinominando.
La perizia poetica di De Santis è evidente: nel tono elegiaco ma cauto, nella ritmica ampia e paziente; nella gentilezza di un lessico policromo e vibrante, le cui sonorità sono sintoniche ai temi espressi; ma è la partecipata riflessione che commuove, lo scoramento che muta in misericordia, il sentire che tracima dal taciuto, ed esprime il collettivo. E il finale tronco, che sa il prosieguo nello svanire, e la dissolvenza della parola, anche scritta. È con l’auspicio di “lealtà di linfe e molecole, un’onda” in cui ogni creatura è prodigio esilissimo, in lucente sparizione, che l’opera volge all’interminato termine: reimparare il ritorno a materia primordiale e nobile, in perenne metamorfosi.
E peculiarmente, gli umani: forme vocate, sì anch’esse, al dissolvimento, prone al degrado in opere ed essenza; ma presenti in spirito, deste a loro stesse, dunque ontologicamente afferenti alle intelligenze sottili, ai soppesati equilibri che innervano l’esistente. Uomo verticale, bisognoso di asse celeste, di orientamento al mistero, quale esso sia; che sappia la leggerezza, il fluire nella meraviglia, che abbia cura del proprio baricentro sacro; la creatura sul margine, gravata di ombre e opacità, cui è possibile radicare solo nell’invisibile.
Nessun assioma, nessuna ideologia. Ma, nei versi finali, come una percezione lievissima, un passaggio di luce: “nel fiato che attraversa lo spazio, l’alone, la risposta”. E viene alla mente Elia, quel vento leggero:
Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello
(1Re 19:9-13)

*
Da: Mario De Santis, Corpi solubili (Samuele Editore 2023)
(DOVE, DOMANI)
La notte non si divide, neppure il Tevere
che ci chiude in due città. Così il tempo delle assenze
è stato una giostra e una rettifica leggera al mondo
quella sorgente di montagna mai raggiunta
– eppure il nulla di melma del sottofiume
esiste ancora: lava di foglie, schiuma spenta,
tende di rifugiati e spazzatura
una bava del passato e un gorgo –.
Adesso non c’è tempo per dire cosa non è stato,
come sarebbe se domani – in un’ora senza data,
con musica infelice e in feste di settembre –
fosse visibile nel disastro, l’irreparabile
che annuncia un cambio di stagione.
Tutto avrebbe segnalato (visto prima) la sottile
differenza tra il sogno della morte
e un altro giorno in cui saresti stato qui.
Lo chiameremo, in ogni caso, storia.
(Roma, vigilia di Pasqua 2003)

*
La nuvola scura che muore con la luce ha il cielo sopra
e l’ombra inutile dei gas, il viola-carne delle impurità.
dalla piazza più grande di Milano sale sui tetti tra le antenne
la processione di insetti avvelenati, di triboli dell’anno
e gole rosse un disegno dell’ornato forma incendi.
La vita fragile che annulla, scava noi, rifugia tra le pieghe
di abiti costosi, dalla vetrina riflette il lampeggiante
(soccorso in overdose, l’adolescente a chi sorride?).
Esistere è il sisma lucente dei neuroni, le cellule di corsa,
la materia morbida, il veleno. una cera dell’affanno,
della pena di lavoro tradotta nelle ore.
da un punto all’altro della città, senza battesimo di piogge
il tempo si dissolve in un sereno acido, libero dal peso verticale,
dai giorni confinati e innumeri, in uno spazio livido
che si fa più grande di ogni suo creatore.

*
nudo presente, buchi e stazioni ordinate
di quella calma che ha l’olio dipinto, con la domanda
che scarcera e poi non c’è che le chiavi, le intenzioni di dolo
tutte separazioni di elementi che ci lasciano esistere.
non solo: come di fronte a quel regno aperto di cenere
che sono scavi e sono gru, trivellazioni, la fretta di chi passa
diventa fuga di colori, sciarpe come pennelli, tutto gocciando
copre un sentiero che si era aperto nel verde e nel caos;
qui nel venerdì di una città posso accettare che né la prigionia
né il troppo vasto lago misuri le distanze
moltiplicate dalle agonie, quel fiatare braccato
e stretto in un vagone pieno, ore di punta e solitari
in un macello non previsto,
poi calmi, a lavorare in un piano vuoto e intero.

*
La mosca appesa al vetro parla nella luce
ai cani assetati, ai passaggi dei tir, ai comizi elettorali
e a un sole folle – si vive nel ronzio pronunciato
e colloso. una sentenza, una costante tonale
che informa di malattie e ossigeno, dura solitaria
e tutti le somigliano. un la che tiene la mente
al filo dei negozi chiusi uno dopo l’altro, lungo il bordo
della provinciale (si lasciano cadaveri, si ascoltano promesse
se ci si vive a lungo). Rimanere in questo lato del mondo
significa assistere all’espansione delle spore, formate a chiazze,
ecografia di muri, vanno a oltrepassare la vita. in superfice
diventa eterno il pulviscolo, la scia di batteri, i funghi. Sulla finestra
solo la mosca misura le distanze, oltre i depositi non custoditi
la meccanica di una materia che non sa. tranne volare,
partecipa nel tempo a una pace senza fare, immobile atto vivo
di compresenza in corpi, soli, sdraiati senza alcuna forma di risposta.

*
(DOPO LA STORIA, I FIGLI)
nei sogni non c’è mai il cielo o una parete di carbonio, un velo
dove guardare sangue nella cenere, senz’anni, né filo di coriandoli.
Conta il risveglio, compare dal fondo un lascito, somiglia
a un calcio all’aria di ragazzo, gli occhi gialli,
lento, impreparato ad avere in punta i nervi che colpisce,
le sneaker sporche, la smania a friggere per l’impossibile.
il piede: un conio sulla porta chiusa, il vento fuori
che decide e urla, ombra di tutti i nostri agguati. La storia genera
perché niente splende se non brucia, come le guerre
il tempo delle colpe si consuma in una rissa.
è dopo anelli di morte che si ricomincia a capire gli anni
da un capillare occluso, dalla spirale di tagli, di abbandoni, l’aria
vuota di una conchiglia – e l’ascolto cieco del rumore,
al fondo dove i figli dei fantasmi sono un unico corpo immobile
che ci sopravvive.

*
A chi abita nei pressi del Monumentale manca
la parola cimitero. Si scende alla stazione sotterranea
senza malanni, né bende, tra scheletri di geometrie. il nome
è quello (un aggettivo) e fa della morte un eroismo in fototessera;
i cittadini laboriosi (ora da Cina, dal Marocco) si tuffano davvero
nella terra guasta di Milano; sotto si viaggia sereni,
sopra la disfatta dei visi di marmo e calce, una galleria di morte
senza orrore. Qualcuno lava il pavimento (le tombe sono case),
cisi arriva tutti insieme, alla velocità che ha avuto il novecento; l’isola
dei morti, vicina (i vivissimi e ubriachi, i turisti di sé) parlano
urlate psicologie, esotismi. Se possiamo scegliere l’uscita, l’obbligo
è rimanere nella vita, nonostante si sosti tra i dimentichi
di tutto: del capolinea, dove non siamo stati mai;
del conseguito sangue, atteso in senso inverso
che invece non verrà; del fatto che sia tardi.

*
in forse il mondo, per la pioggia distesa che ritarda
e l’erba frusta, dall’altro lato di un deposito di latte
e di cristalli antiproiettile. non c’è l’universo,
solo questo spiazzo pulito che sprofonda su sé,
intorno piante, senza memoria e posti-macchina,
adesso vuoti. Qualcuno in piedi pesa,
in un rimbalzo di saluti, il vento asciutto che precipita intorno
calcolando quanto ci ricordi anni compressi
ogni dominio di invisibile, così affollato di rumori.
L’acqua di lacrime non basta, le foglie sono gialle,
il caldo le ustiona nel riverbero dal tetto di alluminio.
C’è dolore nell’arma di un bisbiglio che denuda,
ogni volta diviene un’attrazione e una sete
che non va oltre quel niente del parcheggio.
i volti sciamano all’indietro nell’opaco della polvere,
sembrano un ricordo, ma è l’ora esatta.
“Ciao”, si sente appena, e poi “a domani” (come si chiama?)
nient’altro, se non che c’è fatica, nessun lavoro.
La siccità non fa che confermare che si resta
in dissolvenza, fuori dall’orario, come un’estinzione
dei contatti. Facendo pochi passi a piedi: oltre il cancello
è dove non si è prima, all’ombra delle piante.
non ha senso aspettare i frutti, nemmeno i fiori. Appesi ai rami
restano un buio del possibile, un perimetro, solo campo
dove il sentiero va in circolo, nevrotico
scavando con i piedi nella polvere, deposto a bordo strada.
Anche se poveri, viene il turno di miceti e dei riverberi
tutto declina in un chiarore, nessun inganno e segreto
nella prossimità di cellule e cenere, i saluti restano in aria,
il resto inizia senza ieri

*
(LA NOTTE, DENTRO)
è nel muro di calce viva la telecamera, che sgrana
i volti e i corpi senza baricentro, sconfinati:
è un panorama al fosforo, di feste all’improvviso, bar,
la frenesia della città d’estate circondata da incendi periferici.
Le conseguenze mai capite dei respiri, con gli anni
che strappano i calcoli alla fuga sbilanciata di mani,
di gomiti feriti in una serie di vite di una stessa scia
che si allontana. E chiamano nel buio, ma non sono inseguitori.
La definita pace è nei ritratti-file, in mega-archivi di controllo: i visi
malcerti nello sguardo, pallidi e senza febbre – e noi.
tutti durare, per essere scordati, dopo la dissolvenza.
Ed è sotto questo muro illuminato l’accampamento
rasoterra, una sete di pensieri, il calore postumo, la sera.
nel fresco torna l’ombra moltiplicata dei fumi e vene scollegate
di vivi, visitatori del museo di elenchi telefonici. uniti
da mappe casuali che non trattengono nemmeno un nome
(ancora più che i sogni, lasciati così vaghi). nel refolo, un assurdo
mormorìo dal fondo della via, all’improvviso tace.
nel fiato che attraversa lo spazio, l’alone, la risposta.
ispirata a Christian Boltanski,
Les abonnés du téléphone, 2000, installazione

*

Mario de Santis è nato a Roma. Ha scritto tre libri di poesia: Le ore impossibili (Empiria, 2007), La polvere nell’acqua (Crocetti, 2012), Sciami (Ladolfi, 2015). Laureato su Cesare Viviani con Biancamaria Frabotta. Oltre ad aver condotto trasmissioni culturali in radio per circa trent’anni, ha scritto per “Poesia”, “Atelier”, i blog “Nazione Indiana”, “Doppio zero”, per “Robinson” di Repubblica e realizzato cicli di interviste per Repubblica TV. Attualmente giornalista di area digitale del Gruppo Gedi, scrive di teatro per Huffington Post e libri per “minima & moralia”. Collabora con il semestrale “K” de Linkiesta per la sezione poesia e cura la rubrica settimanale “Certi versi” su “Specchio”, inserto di La Stampa