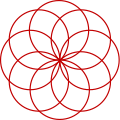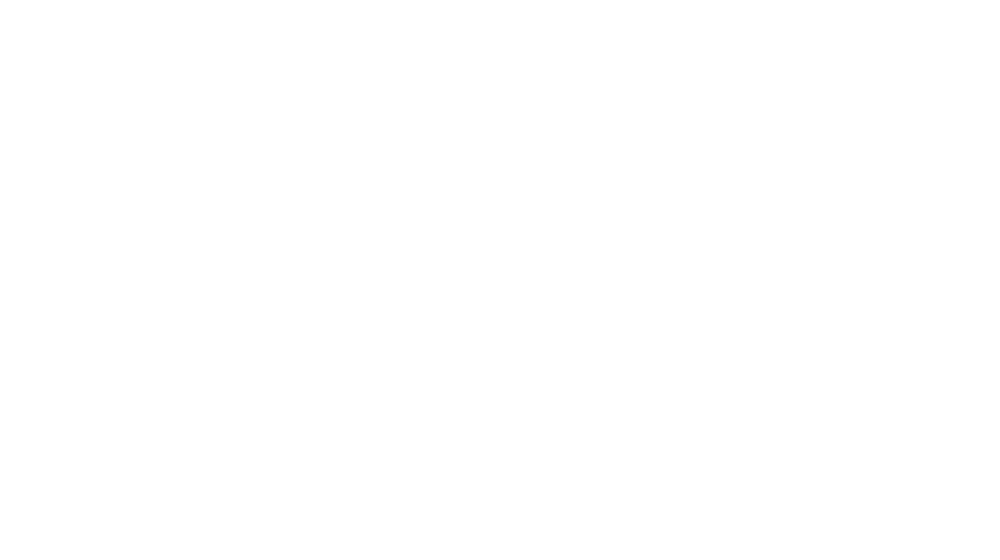Marco Saya Edizioni 2021
C’è un momento dell’anno, quando il gelo apre le sue valve alla stagione chiara, in cui soffia da sud est un vento caldo, ruvido di sabbia. Cinquanta (khamsīn) sono i giorni in cui il suo fiato può sollevarsi, portando sul Nordafrica e sulle terre d’Arabia un tepore scabro, fragile, a intermittenza.
Così le parole di Maria Grazia Galatà nella sua ultima silloge (Khamsin, Marco Saya Edizioni 2021) agglutinano in fraseggi istantanei, epifanici, per poi farsi polvere e riaggregare in nuovo verbo, per «dare spazio, via via, all’affioramento dell’essenza in un motto» (come Gian Ruggero Manzoni che accompagna, in prefazione). Che si tratti di «inattesa rivelazione» e non «ossessiva ricerca» appare chiaro dalla docile flessibilità del dettato, che mai nega né afferma, ma piuttosto offre, aprendo.

Dilatare i varchi di percezione, questo l’intento, per evadere dalle rigide strutture razionali, che suppongono il determinismo causale come movente unico del creato, lasciandolo costretto e ferito; affermare invece il puntiforme e l’inatteso, che, nell’evocato enigma, rivela. C’è una ritmica di suoni e immagini che scandisce il reale, ed è a quel fondo invisitato che la poetessa rivolge sensi e intelletto, nel tentativo di recuperare una matrice di appartenenza al teatro del vivere, e di porgere corpuscoli di votata rivelazione.
La raccolta esordisce tracciando nell’aria una soglia, «la fine di un luogo», ignota sponda che ridà all’alba la sua natura di perpetua domanda. Nel silenzio, il posare. Il farsi indugio e armistizio, pace per intuire, nel buio di ogni conoscenza, quei pochi lembi di «assolutezza».
Tra esistenze incerte, stretti all’imperio dell’inessenziale, lasciarsi ricreare passivamente, come fossimo germoglio, è la possibilità salvifica: bagnarsi nel fluire che ci contiene, aver cura di abbandono e perdita, identificarsi nella propria impotenza creaturale, osservare con tenerezza quell’ostinata speranza che sempre ci ridà alla luce, ci rinasce, immaginifica come opera d’arte.

In Galatà vi sono istanti d’intensità liturgica in cui tutto pare percepito in unità: su un limen di estinzione e risveglio, di catastrofe sensoriale, che si fa palesamento. Addolora la mancanza di un fermo annuncio, stabile nel bene, che rassicuri dall’agglomerato degli eventi: «muto arriva agli occhi questo tempo», nella «luce violenta e strana» di «quest’oceano che avanza». Straniera e incompresa, la notizia sottesa è barbara agli occhi, temuta ostile. Unico strumento per traslare il codice, la poesia. Tra «pagine sporche», non rifinite, «di confine», salvare una sola parola, la più irrimediabile e perduta, quella oltre il punto, oltre la frontiera dei mondi tracciati.
Così Daumal: «Nomina, se puoi, la tua ombra, la tua paura / e misurale la circonferenza della testa […] se osi rompere questo silenzio / tessuto di risa mute – se osi / senza complici far scoppiare la bolla, / lacerare la trama, / da solo, completamente solo […] venire nudo verso la madre dei morti / nel cuore del suo cuore riposa la tua pupilla //senti che ti chiama: figlio mio, / senti che ti chiama per nome». (René Daumal, «Basta un’unica parola», da Controcielo, traduzione di Damiano Abeni, edizioni Tlon, 2020).
È questa la parola – nell’istante – definitiva, che vedremo innalzarsi in volo, ergersi come poesia.
E Galatà: «La verticalità del gesto ha notti lucide / di insonnia»: ecco l’affinarsi del poeta, vertice proteso, assediato, mai salvo nella sua particolarissima salvezza. È labile ogni incontro, «mentre lo sguardo sofferma l’ora» di un universo fluido, che freme in sospiro, in protratte «assenze» che segnano al «distacco», e tuttavia al ritorno: perché ricade addosso un senso di mite compostezza, un dilatarsi alla tregua: «minuta muta ricordi – le ferite di anni / abbiamo perso i momenti migliori – dici / la vita è un abbandono ed era tutto vero / ci parleremo del vento e poi del mare / della pioggia di questa neve che torna / nel punto fermo dopo il passo del mondo».

Già altrove, in Galatà, era assidua la dialettica tra moto e posa, tra concitazione e quiete: «il coraggio ha l’assedio diacronico / improvviso – la costruzione / della convinzione che tutto vada bene / è pura illusione in questo spazio/tempo / curvo – forse un treno che sfiamma lungo / costa e mare ha memoria di questa notte / di strana saggezza» (L’allarme del crepuscolo, Marco Saya Edizioni 2020); attitudine che esita sovente in consapevole riconsegna di sé al necessario custodirsi, ritorno esistenziale per riacquistare prossimità al centro: «le foglie sfogliano lungo il viale / una voce insegue una farfalla /mentre lo sguardo sofferma l’ora / e / il mare / lontano / sospira il vento».
Pure, c’è un «tempo parallelo» che è sospensione, esistenza astratta e visionaria, centratissima: «siediti accanto al punto di giunzione un passo / dopo l’attesa – canterai per me questa / percorsa incertezza lì nei punti della caduta / questo niente che ci accarezza / di rare rarissime accensioni».
Così è dato essere qui, nella dimensione principe dell’umano, che è errore, disorientamento: «ti scrivo dall’inferno mio indefinito / nel freddo lungo distacco o la nascita / di un’ossessione lucida e fanatica – il tempo / questo tempo – vicino agli errori // conseguenze capovolte»; si è nel fluire, nel precipitare, ma ancora nel battesimo possibile, quello d’esser chiamati per nome, come Galatà dice, ancora, altrove: «è un velo di tempo questo stupore / la linea della distrazione o il lato / della circostanza – quella mancata / turbolenza mentre ti chiedo di non /chiedermi – ma darmi una forma / quella dell’amore a un certo termine» (L’allarme del crepuscolo, op. cit.).

La vita, sembra dire la poetessa, porta lo stigma corale del mancato, del disatteso. La poesia sorge lì, da «quell’ora infinita» che plana nella «potenza del silenzio», fino allo scaturire di un «esodo» che diviene «parola in codice», anagramma del buio: «senti il silenzio in questo passato abbandono / ch’è monumentale e bisbiglio e tutto vago / là dove l’unica forma è sentirsi parte quando / tutto cambia».
Khamsīn si chiude con un magistrale monologo, dove paesaggi infranti rubano al cuore parole esauste: «Eppure / oppure volevo solo ammalarmi di te – delle / briciole nascoste ai lati del campo nella cura del / passaggio oltre la notte mentre manca quella parte / che batte ai polsi nel giaciglio», siglando un diario di alto sentire, veste quieta nel tremito, nella scossa che sfasa e naufraga, e infine posa in amore.
Nulla accade tra le dita che sia nostro. Il poeta è «pagina sbagliata – dislessica con la / grammatica disperata» e ogni creatura è «precarietà di sangue e giorni d’ombre». Eppure è la stessa «natura del mare», mutevolmente immobile, che insegna il talento del flettere, della resa che danza.
«L’urto continuo e armonioso dei contrari – diceva Cristina Campo – conduce l’animo a una sorta di ardente immobilità, lo colma fino all’orlo di una vita che non trabocca perché il suo stesso muoversi la frena», e qui citava Dante: «Dal centro al cerchio e sì dal cerchio al centro / mòvesi l’acqua in un ritondo vaso / seconda ch’è percossa fori o dentro» (Paradiso, XIV, 1-3). Nell’abbandono il ritrovarsi, nell’esilio il ritorno. Questa l’incompresa nostra matrice, da riconquistare con devoto cuore, passo dopo passo.
(I.B.)